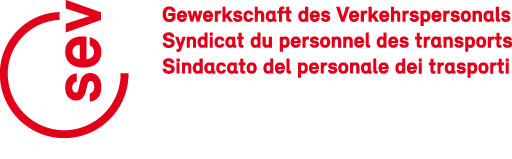Oggi la rete-piattaforma permette di esternalizzare una quantità crescente di mansioni e competenze
Se un algoritmo ci governerà
Come sta il mondo del lavoro? Pessimamente, come ci spiega il professor Lelio Demichelis che analizza i profondi cambiamenti nel mondo del lavoro, sempre più frammentato, uberizzato e individualizzato. Un mondo in ampia trasformazione che comporta delle sfide anche per i sindacati.

Professor Demichelis, la rivoluzione tecnologica sta sovvertendo il mondo del lavoro e delle professioni. La robotizzazione di molte funzioni produttive e la crescente digitalizzazione hanno un notevole impatto e lo avranno a maggior ragione anche in futuro. Quale la sua constatazione sullo stato di salute del mondo del lavoro?
Pessima – e non perché sia contrario alla tecnologia, anzi. Ma ciò accade in ogni fase della rivoluzione industriale. Ogni volta si crea e (soprattutto) si distrugge lavoro, ma ciò che è ancora più importante – e su questo occorre in primo luogo ragionare - è che ogni volta si trasforma nel profondo la società, che assume una «forma» organizzativa sempre più tecnica. Alla Silicon Valley che ci vuole tutti sempre connessi - altrimenti non riesce a prendere i nostri dati, essenziali per fare profitto per sé - si è sovrapposta negli ultimi trent’anni l’ideologia neoliberale basata sulla trasformazione della società in mercato e della vita in competizione. Di diverso, oggi, c’è che la pervasività e l’invasività delle tecnologie sono «n» volte maggiori rispetto a ieri; e che oggi il «machine learning» e gli algoritmi che si programmano da soli stanno alienando gli uomini sia (marxianamente) dalla proprietà dei mezzi di produzione, sia dalla stessa «decisione sovrana» su «cosa fare» e «come farlo» e per quale «scopo». Stiamo cioè delegando sempre più la nostra vita – fare, consumare, vivere, informarci, comunicare, amare - alle macchine e agli algoritmi: la grande differenza con la tecnica del passato è qui.
La triangolazione tra persona, tecnologia e occupazione non è nuova. L’economista britannico John Maynard Keynes già nel 1930 parlava di «disoccupazione tecnologica». Cos’è cambiato oggi rispetto al passato?
Keynes (era il 1930) parlava di disoccupazione tecnologica come di una nuova «malattia» delle società avanzate, dovuta alla scoperta di sempre nuovi strumenti economizzatori di manodopera e la cui invenzione procede a ritmi più rapidi di quelli con cui si riesce a creare nuove occupazioni per la manodopera espulsa. Keynes la definiva tuttavia una «malattia» transitoria perché credeva nel progresso, mentre la tecnologia di oggi non solo ricrea e moltiplica il disequilibrio di allora tra occupazione persa e creata, ma lo fa molto più velocemente di allora, per cui è difficile anche immaginare «effetti compensativi» positivi a lungo termine della disoccupazione odierna, quando già domani probabilmente saremo confrontati con una nuova disoccupazione tecnologica: che ormai non è transitoria, ma sistemica/strutturale, perché non dobbiamo dimenticare che la «distruzione creatrice» schumpeteriana (oggi ridefinita come «disruption») ha bisogno appunto di distruggere (molto e sempre) a prescindere dall’utilità sociale delle innovazioni. Di più: oggi il sistema ci dice e impone che «dobbiamo adattarci» al cambiamento/ «disruption». Ma se non usciamo da questo determinismo tecnologico saremo sempre più governati da un algoritmo. E passeremo (o siamo già passati) dalla democrazia alla algocrazia.
L’avvento di Uber ha pure profondamente cambiato il mondo del lavoro sdoganando il modello di uberizzazione del lavoro. Con quali insidie e conseguenze?
Uber ha sfruttato la nuova forma di organizzazione del lavoro permessa dalla rete. Ricordo che il sistema - che io chiamo tecno-capitalista - si basa su un «doppio movimento» sempre uguale anche se apparentemente sempre diverso. Ovvero, prima bisogna suddividere, individualizzare, parcellizzare il lavoro (e i consumi e la vita) per poi ricomporre, integrare, totalizzare le parti suddivise in qualcosa che sia maggiore della semplice somma aritmetica della parti suddivise - e questo qualcosa si chiama organizzazione e connessione in rete e «internet delle cose e degli uomini». Se nel ’900 questa ricomposizione/organizzazione di uomini e macchine si chiamava catena di montaggio e aveva bisogno di un luogo «fisico» concentrato dove realizzarsi (la fabbrica, l’ufficio), oggi la rete-piattaforma permette invece di esternalizzare una quantità crescente di mansioni, competenze, professionalità e di pagarle on demand, cioè quando occorre e per il tempo che occorre, a sua volta evoluzione o involuzione del just in time degli anni ’70.
Ancora prima di esserci, il lavoro cambia, richiede una flessibilità preventiva. La narrazione delle opportunità digitali svanisce però di fronte alla precarizzazione del lavoro, alle ambiguità del cosiddetto «digital labor» e all’illusione dell’auto imprenditorialità promesso dalle piattaforme. Quale il suo sguardo tra opportunità e pericoli?
L’autista di Uber «crede» di essere «imprenditore di se stesso» perché ha i mezzi di produzione (l’auto, lo smartphone), ma dimentica che il vero «mezzo di produzione» è la piattaforma. Mentre il digital labour è più lavoro sfruttato che remunerato, sconfinando nel lavoro gratuito. Siamo entrati nel «capitalismo delle piattaforme». Ma la flessibilità nasce negli anni ’70, un decennio di stagnazione, inflazione e disoccupazione da cui il sistema aveva bisogno di uscire con una nuova fase di «distruzione creatrice» - e arrivarono la globalizzazione, la deregolamentazione dei mercati finanziari e del lavoro e la rete e oggi la digitalizzazione.
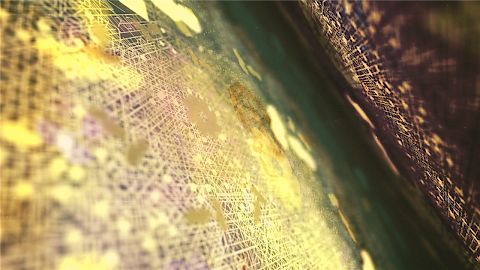
Secondo un recente rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro il lavoro salariato rappresenta solo la metà degli impieghi nel mondo e tra questi solo il 45% sono permanenti a tempo pieno. Una situazione che lancia nuove sfide anche a livello democratico e sociale. Come ridisegnare la continuità/prevedibilità del salario, la protezione sociale e la salvaguardia dei diritti di chi lavora nell’era digitale e dell’uberizzazione?
Ford non amava il sindacato e neppure Taylor («un intralcio alla libertà d’impresa»). Oggi, la messa in crisi del sindacato passa dalla tecnologia di rete e dal falso individualismo neoliberale che individualizzano il lavoro permettendo all’impresa di organizzarlo senza l’intralcio del sindacato e con contratti individuali invece dei contratti collettivi. Divide et impera, grazie alla tecnica. Dal 1945 alla fine degli anni ’70 il capitalismo è dovuto venire a patti con la democrazia. Ma dagli anni ’80 si è rimesso al comando del mondo, ha sostituito la competizione alla solidarietà (poco funzionale alla «distruzione creatrice») ed ha riportato il lavoro alla condizione di una merce sempre più low cost. Se per una parte del ’900 la democrazia è riuscita ad andare oltre i cancelli delle fabbriche, oggi occorre andare oltre i «cancelli» delle fabbriche-piattaforme, su fino alla Silicon Valley - obbligandola a farsi carico dei costi sociali da essi stessi prodotti con le loro innovazioni (troppo facile tenersi solo i profitti).
La sfida riguarda anche i sindacati, che per anni hanno costruito la loro base sindacale e il loro rapporto di forza sui luoghi di lavoro, nelle fabbriche, a contatto con le persone. Se i luoghi di lavoro diventano virtuali, che strade e strategie restano ai sindacati?
La prima cosa da fare è prendere consapevolezza che oggi la tecnica è un potere nuovo e che non è governato dal demos, cioè dal popolo sovrano. Che è un potere anche oltre l’impresa. Per arrivare a questa consapevolezza occorre uscire dalla «favola tecnologica» che ci illude che la rete sia libera e democratica, che vi nasca un’ economia della condivisione postcapitalista, che Facebook sia veramente «social». E se il neoliberalismo si proponeva di demolire la società in nome della promessa di una libertà assoluta degli individui, occorre dire con forza che quella promessa era falsa e che l’io non esiste e non è libero se non esiste anche un «noi» altrettanto libero. Mentre al sindacato occorre ricordare che non basta contrattare gli algoritmi o con gli algoritmi (che non conoscono il concetto di democrazia) - sarebbe un agire solo a valle dei processi in atto - senza controllare ciò che, a monte, li determina.
La digitalizzazione viene evidentemente spinta da chi la comprende e da chi ne intravvede i benefici. Il rischio è di trovarci confrontati con una società duale: «chi ce la fa» e «chi non sa come fare». Rispetto alle altre rivoluzioni industriali, quanto è diversa questa?
È diversa nei termini che dicevo all’inizio ma sempre uguale in termini di «doppio movimento». Perché la tecnica non è più un mezzo e non è neutra ma è qualcosa che sta diventando pericolosamente autopoietica, cioè capace – e questo sono appunto gli algoritmi – di essere allo stesso tempo «il soggetto che ordina e l’oggetto dell’ordine da esso stesso creato». La tecnica ci è sfuggita di mano. Dobbiamo riprenderne il controllo.
Françoise Gehring
BIO
Lelio Demichelis, classe 1956, è laureato in Giurisprudenza. Docente di Sociologia economica presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, insegna anche alla SUPSI a Lugano. Collabora con diverse testate giornalistiche come «MicroMega», «Sbilanciamoci.info»; «RSI». È autore di numerose ricerche e pubblicazioni, tra cui le più recenti:
«Sociologia della tecnica e del capitalismo», Franco Angeli, Milano, 2017;
«La religione tecno-capitalista», Mimesis, Milano, 2015.