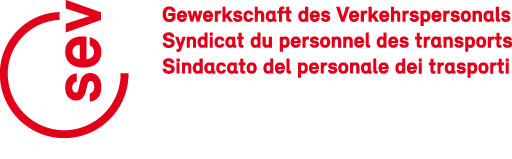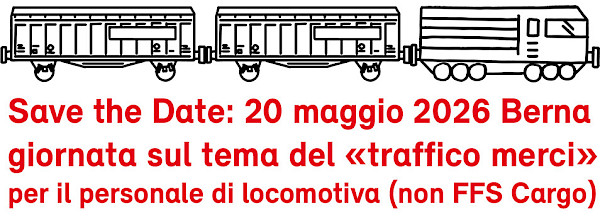Il trasporto con il bus ha un futuro promettente
Molte reti di bus devono essere rivalutate
Nelle città e negli agglomerati svizzeri vi sono molte più reti di bus che di tram. Esse vengono ampliate solo in modo puntuale e molto pragmatico. Esperti di trasporti chiedono però di aumentare il livello di prestazioni, anche perché la velocità commerciale sta diminuendo.

Anche il sondaggio condotto da contatto.sev presso le aziende di trasporto urbane conferma che, nelle città e negli agglomerati, i bus diventano sempre più lenti. Negli ultimi anni, la velocità d’orario è diminuita «di alcuni chilometri l’ora» precisa l’addetta stampa dei trasporti pubblici di Losanna (TL) Valérie Maire. Le cause sono da ricercare nell’incremento del traffico privato.
Da Winterthur e Zurigo giungono ulteriori conferme. «Siamo tendenzialmente sempre più lenti», afferma Daniela Tobler delle imprese di trasporto di Zurigo VBZ, che oltre all’aumento del traffico, ravvisa un’ulteriore causa nella «riconquista delle superfici di trasporto da parte della mobilità lenta».
Questo fenomeno colpisce i tram in misura molto minore, dato che essi dispongono spesso di un proprio tracciato, sul quale hanno la priorità anche rispetto ai pedoni. Qualche avvisaglia però c’è: a Zurigo, per esempio, la velocità media dei tram è diminuita negli ultimi 10 anni da 17 a 16 km/h.
Evoluzione preoccupante e cara
Per il trasporto pubblico, si tratta di un’evoluzione negativa, in quanto la minor velocità compromette spesso anche l’affidabilità dell’orario. Nelle ore di punta, quando alle fermate vi sono numerosi utenti, i bus si ritrovano bloccati in colonna. La velocità è uno dei fattori chiave per il successo di tram e bus, condizionando la scelta del mezzo di trasporto. Inoltre, ha ripercussioni anche sui costi. A parità di offerta, bus lenti richiedono l’impiego di un maggior numero di mezzi e, quindi, di più personale. Aumentano di conseguenza i costi per le aziende di trasporto e per le collettività chiamate a contribuire al finanziamento.
La velocità d’orario dei bus circolanti nelle città svizzere è spesso inferiore ai 20 km/h. A Berna, per esempio, sulle linee principali al di fuori degli orari di punta, si registra una velocità media di 17,9 km/h. A Losanna, la frequentatissima linea 9 (Lutry–Prilly) viene percorsa nelle ore di punta a 15 km/h, che aumentano a 20 nelle ore serali.
Provvedimenti conosciuti
Numerosi dei provvedimenti che permetterebbero di accelerare i mezzi di trasporto pubblici sono noti, ma vengono realizzati solo in parte, laddove le condizioni materiali e finanziarie lo permettono. I principali sono la creazione di corsie preferenziali, di semafori che danno la priorità ai bus, oppure la creazione di fermate in corsia, anziché in spiazzi laterali per evitare al bus fermo di essere superato dalla colonna di autoveicoli, nella quale deve conquistarsi lo spazio per rientrare. A volte però questi spiazzi sono necessari per permettere al bus di compensare eventuali anticipi sull’orario senza intralciare oltremisura il traffico.
Vi sono infine anche le modifiche ai veicoli, come i piani ribassati o l’aumento del numero di porte, che permettono di accelerare la salita e la discesa degli utenti. Provvedimenti che l’aumento degli utenti, anche di corse in coincidenza, della maggior parte delle aziende hanno reso ancora più importanti. «In una certa misura, possiamo affermare di esser vittima del nostro successo» ci conferma Thomas Nideröst, direttore dei bus urbani di Winterthur.
Thomas Ledergerber, capo del management della rete di Bernmobil, ha presentato un’ulteriore proposta, consistente nell’aumento della distanza tra le varie fermate che, nel settore urbano, dovrebbe idealmente situarsi tra i 400 e i 500 metri. A Berna, per esempio, questa distanza è spesso inferiore. «Sopprimere fermate è però una decisione molto delicata e difficile». Bernmobil ne ha fatto l’esperienza, ritrovandosi confrontata ad un nugolo di proteste quando ha comunicato la soppressione di una fermata.
Ostacoli politici
Anche altre idee vanno a cozzare contro ostacoli di carattere politico. La creazione di corsie preferenziali nelle stradine dei nuclei cittadini sottrae forzatamente spazi al traffico individuale, scatenando le opposizioni delle associazioni di automobilisti. Lo stesso capita spesso con i semafori prioritari per i bus, che penalizzano inevitabilmente gli altri utenti della strada. «Qualcuno ci va sempre di mezzo» commenta Ledergerber.
Il professore al politecnico Ulrich Weidmann, direttore dell’istituto per la pianificazione del traffico e dei sistemi di trasporto (IVT), ha constatato che «riconoscere le dovute priorità al trasporto pubblico negli ultimi tempi non dà più gli stessi effetti».
Per questo si cercano nuovi adeguamenti puntuali, come a Winterthur, dove Thomas Nideröst propone di realizzare semafori che spostino le colonne laddove è possibile creare corsie preferenziali per i bus, «in modo da permettere loro di aggirare le colonne».
Weidmann ha un’altra proposta, mirata soprattutto alle periferie che potrebbero beneficiare di corsie preferenziali, da realizzare laddove esistono già doppie corsie. Una di queste potrebbe essere dedicata ai bus solo nel momento in cui essi stanno per sopraggiungere tramite un’apposita segnaletica.
Pianificare come i tram
Weidmann ritiene urgente migliorare l’offerta di bus. «Non dobbiamo limitarci alle rotaie, dobbiamo fare progressi anche nel campo dei bus». Secondo lui, la chiave per migliorare quest’offerta non è nei veicoli o nella loro trazione, quanto nell’infrastruttura. La pianificazione di linee di bus molto frequentate deve ricevere gli stessi riguardi di una linea di tram, invece di essere considerata solo in modo marginale. «Il bus è un sistema di trasporti che necessita di infrastrutture adeguate su tutto il suo tracciato ».
Oltre alle corsie preferenziali, un riguardo particolare va prestato anche alle fermate, in particolare quelle che offrono coincidenze. Sino ad ora, la loro ubicazione dipendeva da esigenze più che altro della pianificazione territoriale, mentre in futuro al centro dell’attenzione vi dovrebbero essere le esigenze dei viaggiatori e dei bus «mentre il trasporto individuale, flessibile per definizione, deve essere deviato di conseguenza ».
Nuove soluzioni a Losanna
Questi sistemi vengono definiti dagli specialisti del ramo «linee bus con offerta di alto livello », ambito nel quale Losanna sta ritagliandosi il ruolo di precursore, elaborando un «Réseau des axes forts» (rete delle linee principali) che dovrebbe andare in servizio nel 2018 con tre linee di bus a «alto livello di servizi (BHNS)».
Queste linee prevedono un tracciato dedicato e la priorità assoluta ai bus sugli incroci, incrementando così l’affidabilità e la velocità commerciale dei bus. Quest’ultima dovrebbe passare dagli attuali 10 km/h ad almeno 18 km/h. La cadenza elevata di circolazione di bus a due articolazioni, con capacità per 150 persone e accesso ribassato dovrebbero contribuire all’aumento dell’attrattiva di queste linee.
Passo a passo verso il tram?
Ma su queste linee non sarebbe a questo punto meglio rivedere l’impiego di tram, in grado di accogliere sino a 250 persone?
Secondo Ulrich Weidmann, non vi sono indicazioni precise sul numero di viaggiatori oltre il quale sarebbe opportuno passare al tram. L’offerta di una linea di tram percorsa ogni cinque-dieci minuti può essere coperta anche sui tronconi ben frequentati, anche da bus che circolano ogni due-tre minuti. Vi sono poi anche considerazioni di ordine pianificatorio, secondo le quali la creazione di una linea di tram può contribuire a rivalutare un quartiere o un agglomerato.
Oggi vi sono diverse città di media grandezza, tra le quali Bienne, Lucerna, Winterthur e Lugano, che stanno riflettendo alla possibilità di reintrodurre il tram.
Per Weidmann, un approccio pragmatico e progressivo permette di evitare il peso di un dibattito di principio, grazie alla possibilità di sviluppare dapprima il tracciato per il bus, per poi renderlo praticabile ai tram quando il numero dei passeggeri lo renderà necessario.
Nideröst è per contro scettico su questi investimenti a tappe, anche a causa del tempo occorrente fino a quando essi dispiegano i loro effetti positivi. «Prima del 2035 sarà difficile vedere un tram a Winterthur» ci dice. Le infrastrutture per i bus devono quindi essere realizzate in modo da durare almeno 25 anni. «La lunghezza dei bus attuali ha permesso di colmare gran parte del distacco dai tram».
Peter Krebs
Il punto di vista del personale
contatto.sev: gli autisti di bus come vivono le continue riduzioni della velocità dei loro mezzi?
Ueli Müller: da decenni, assistiamo all’ampliamento degli orari di punta, in cui il flusso dei pendolari è più intenso. Orari in cui giungo regolarmente in ritardo al capolinea, invece di poter disporre di qualche minuto per tirare il fiato.
Ma quali sono i principali ostacoli al flusso di traffico?
Per esempio, le rotonde, che possono essere percorse solo molto lentamente. In certe stradine di quartiere, inoltre, i bus possono circolare solo a passo di lumaca e ci manca persino lo spazio per superare una bicicletta.
Secondo il personale, quali sarebbero le misure più urgenti?
L’adeguamento degli orari alle circostanze reali e alle esigenze del personale, invece di basarli su valori del tutto teorici.
Reti di bus completamente separate dagli altri vettori, come succede per i tram, potrebbero costituire una soluzione?
Secondo me, la soluzione sta proprio nella separazione dei vettori di traffico, riservando le stradine a biciclette e ai confinanti, creando corsie preferenziali per i bus e creando camminamenti sicuri per pedoni davanti alle stazioni e ai centri commerciali, per esempio con fermate sotterranee. Provvedimenti del genere lasciano spazi alle bici, permettono ai bus di circolare spediti e senza intoppi e mettono a loro agio i pedoni.
Ueli Müller è vicepresidente della VPT e rappresenta il settore dei bus nel comitato centrale della sottofederazione. Lavora come autista di bus a Thun