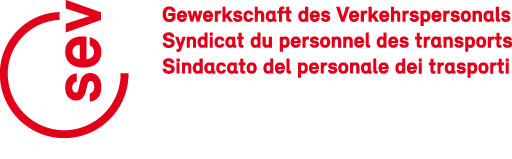Secondo il professor Sergio Rossi, gli insegnamenti delle facoltà di economia non sono più adeguati alla realtà
I volti della concorrenza in una società al bivio
In un suo intervento in occasione della festa per i sei anni dallo sciopero delle Officine di Bellinzona, il professor Sergio Rossi ha fornito una lucida analisi dei problemi attuali della nostra società. Contatto.sev lo ha avvicinato per approfondire alcuni aspetti.

contatto.sev: Professore, lei si occupa di macroeconomia. Cosa tratta questa disciplina?
Sergio Rossi: La macroeconomia riguarda l’insieme dell’economia, con tutti i suoi soggetti: aziende, banche, famiglie, Stato, che interagiscono attraverso diversi mercati, nazionali e internazionali. Da una parte, si analizzano le relazioni tra queste diverse categorie di soggetti, che influenzano molte grandezze economiche, come i prezzi, i salari, l’inflazione e la disoccupazione. Dall’altra parte, si valutano le politiche economiche e i loro obiettivi: la politica finanziaria degli enti pubblici e la politica monetaria della banca centrale, che dovrebbero contribuire alla stabilità economica e finanziaria sul piano nazionale, favorendo l’occupazione e lo sviluppo sostenibile.
In pratica, attorno alla macroeconomia ruota il mondo intero.
Sì, e vi sono due approcci: quello dei neoliberisti, che chiedono in ogni caso meno Stato e più mercato, e quello invece di chi, come me, sostiene che lo Stato e il mercato siano in realtà complementari. La storia ha mostrato che un’ economia pianificata dallo Stato non funziona, ma oggi possiamo constatare anche i limiti di un’economia basata unicamente sul libero mercato. Io sostengo un’economia «sociale di mercato», in cui lo Stato copra le falle del mercato e quest’ultimo svolga i compiti che lo Stato non riesce a svolgere efficacemente.
La virtù, insomma, starebbe nel mezzo.
Certo: un sistema pianificato risulta disincentivante nei confronti dell’impegno personale, mentre il liberismo conduce ad altri estremi, soprattutto dal punto di vista della ripartizione sempre meno equa dei redditi. Il mercato da solo non è in grado di risolvere tutti i problemi. Le stesse FFS ne sono un esempio: non sono nate da una volontà monopolistica dello Stato, ma dal fatto che nessun attore privato era disposto a investire i capitali necessari per la ferrovia. Lo Stato ha quindi colmato una lacuna dell’economia privata, che ora però manifesta un certo interesse per il trasporto ferroviario, limitato tuttavia ai soli settori redditizi. Gli altri settori possono rimanere in mano allo Stato, secondo questa logica mercatistica delle privatizzazioni.
Oggi però sembra che l’unico modo di affrontare i problemi sia di ricorrere alla libera iniziativa dei singoli, riducendo ai minimi termini l’intervento dello Stato.
È anche una questione di retorica. Oggi si parla molto delle lacune e degli errori dello Stato, o di fenomeni come la corruzione, per sostenere che l’unica vera alternativa è il liberismo, dove però l’impegno personale è dettato solamente dalla ricerca del massimo guadagno. E quando diventa evidente che il libero mercato non sempre funziona correttamente, si dà la colpa allo Stato, reo di averlo mal regolamentato.
È possibile regolare questi mercati?
Dobbiamo tener conto del diverso funzionamento di alcuni meccanismi: il prezzo di un bene, come un’automobile, dipende dalla domanda e dall’offerta. Se la domanda aumenta, il prezzo delle automobili tende a salire quando la loro offerta non può essere aumentata. All’aumento del prezzo delle automobili, tuttavia, la loro domanda tenderà a diminuire e questo farà calare il loro prezzo. Sui mercati finanziari, invece, questo meccanismo non è presente. Quando il prezzo di un’azione sale, molti sono attratti dalla possibilità di conseguire un guadagno e decidono perciò di acquistarla, facendone aumentare ancora di più il prezzo, in una spirale che può gonfiare una bolla con il passare del tempo. Quando diventa evidente che il prezzo dell’azione è completamente slegato dal valore dell’azienda, la bolla scoppia e può fare dei danni all’intero sistema. La banca centrale potrebbe decidere di intervenire quando lo scarto tra il valore dell’azienda e il prezzo delle sue azioni supera un limite predeterminato. Oppure lo Stato potrebbe fissare una durata minima per il possesso delle azioni, al di sotto della quale la vendita di queste azioni implica il pagamento di una tassa, come proposto dall’economista James Tobin. Si tratta del resto di interventi che in altri settori, come quello immobiliare, sono già previsti. Non possiamo continuare a pensare che il mercato si regoli da solo. Ciò vale anche per il mercato del lavoro, che deve essere regolamentato correttamente.
Il popolo svizzero ha però appena respinto l’iniziativa sui salari minimi…
Ciononostante, alcune regole sono necessarie. Nestlé, per esempio, ha definito i livelli salariali per i propri quadri che vengono poi declinati tenendo conto del costo della vita nei paesi in cui operano, in modo da offrire loro una capacità di acquisto simile. In Svizzera si potrebbe avere un sistema analogo, che consideri le differenze del costo della vita nelle varie regioni.
Lo Stato potrebbe inoltre intervenire considerando anche fattori come la pianificazione del territorio, la valorizzazione delle regioni periferiche, la gestione del paesaggio, per esempio applicando una tassazione differenziata per incentivare le aziende a insediarsi al di fuori dei centri. I problemi legati al diverso costo della mano d’opera vanno risolti sul lato dell’offerta e non scaricati sui lavoratori che, al di là delle loro qualifiche, sono per natura limitati nella loro mobilità.
Ma non è proprio la concorrenza fiscale a incrementare la pressione sulle strutture e sui lavoratori?
Certo. In Svizzera siamo passati da un sistema basato sulla collaborazione e sulla solidarietà tra i cantoni a un sistema basato sulla concorrenza, nel quale riesce a ridurre il carico fiscale per attirare nuovi insediamenti solo il cantone che già dispone di una massa critica di aziende. In questo modo, la concorrenza fiscale fa parecchi danni, in quanto vanno perse risorse fiscali importanti che dovrebbero essere ripartite tramite una perequazione che aiuti i cantoni più deboli, invece di metterli ancora più sotto pressione. Anche tra i lavoratori si introduce la concorrenza, individualizzando le trattative sui rapporti di lavoro tramite lo svuotamento dei contratti collettivi e l’introduzione di concetti come il salario al merito. Oltretutto, mancando le premesse per valutare obiettivamente gli effettivi meriti individuali, dato che i processi lavorativi sono sempre più interdipendenti, lo stipendio dipende più dalla capacità di trattativa che da quella produttiva del singolo. Individualizzare le trattative rafforza inoltre la posizione dei datori di lavoro, soprattutto se vi è un elevato tasso di disoccupazione. Il pieno impiego non è infatti più un obiettivo di politica economica, ma si colpevolizza il disoccupato, rimproverandogli mancanza di mobilità, o competenze lacunose e, per di più, si peggiorano le prestazioni delle assicurazioni sociali. È un atteggiamento che viene invece ribaltato per i top manager.
Cosa intende dire?
In vista della votazione 1:12, ho partecipato a un dibattito con il CEO di UBS, Sergio Ermotti, che sosteneva che se lui è pagato otto milioni di franchi l’anno è perché li vale e che se il CEO di una banca concorrente ne riceve 10, lui vuole essere pagato altrettanto. Nemmeno qui però esiste un criterio che permetta di giustificare questi compensi, ma l’effetto è completamente diverso.
Come siamo giunti a tanto?
Per due ragioni: la prima deriva dal fatto che i compensi del management oggi devono essere pubblicati e questo ha generato una specie di gara al rilancio. La seconda è che si mettono in relazione questi stipendi con gli utili delle aziende e la loro capacità di versare dividendi agli azionisti (shareholder value), trascurando gli altri portatori di interesse, lavoratori compresi (la cosiddetta stakeholder value).
Pensavo che la pubblicazione di questi stipendi fosse una misura per contenerli.
È in effetti stata pensata così, ma non funziona, in quanto la maggior parte degli azionisti delle grandi ditte sono ormai istituzionali, ai quali interessa il profitto a breve termine. Torniamo quindi alla priorità che viene data alle variabili finanziarie, come viene inculcato agli studenti nelle facoltà di economia e nelle business schools, che insegnano a massimizzare il valore per gli azionisti, quindi i dividendi, indipendentemente dalla missione dell’azienda, e inducono a gestire le risorse umane come se fossero merci.
Questo cambiamento è significativo: una volta c’era il personale, oggi si hanno le risorse umane; un concetto che implica l’idea di una loro costante ottimizzazione, ossia di ricavarne il massimo possibile e poi di sostituirle quando si ammalano o sono troppo anziane.
In questo modo, si trascura peraltro che i dipendenti sono al tempo stesso consumatori e che sostengono, in quanto tali, l’economia. È un discorso di misura: se le classi inferiori vengono pagate troppo poco, alla fine necessitano dell’assistenza dello Stato. Sarebbe quindi preferibile che fossero retribuite meglio, permettendo loro di vivere del loro stipendio.
Lei esprime critiche pesanti a un sistema, spiegandoci che proviene dalle facoltà universitarie. Perché non cambiano dunque gli insegnamenti della scienza economica?
Anche a questa domanda vi sono due risposte. La prima è che vi è comunque una convinzione fortemente radicata che il mercato sia migliore dello Stato in ogni caso. La seconda è dettata dai propri interessi personali e professionali: seguendo questa traiettoria dominante è molto più semplice fare carriera accademica. Stiamo vivendo una vera crisi della scienza economica. Se prima della crisi economica venivano tollerati i ricercatori che sostenevano delle posizioni diverse dal liberismo, oggi ciò non avviene più. Milton Friedman è stato molto abile non solo nel proporre la propria visione neoliberista, ma anche nel discreditare la classe politica e le regolamentazioni di Stato, impregnando tutto il sistema formativo. Dagli Stati Uniti abbiamo quindi importato, oltre che questa ideologia, anche l’intero sistema che si autoriproduce nelle facoltà di economia del mondo occidentale.
Non ne usciremo quindi più?
Nel mese di maggio di quest’anno è stato pubblicato un appello di oltre quaranta associazioni studentesche del mondo intero che rivendica con urgenza di tornare a un maggior pluralismo nell’insegnamento dell’economia. Gli economisti sono scienziati e, in quanto tali, devono poter approfondire i confronti tra paradigmi diversi per trovare le migliori soluzioni ai problemi del nostro tempo. Sarebbe fondamentale che a questo livello vi fossero più visioni, per rispondere adeguatamente alle sfide del 21° secolo. Siamo però rimasti in pochi a sostenere un dibattito critico sui fondamenti dell’economia politica e una visione diversa, che permetta realmente di uscire dalle difficoltà in cui ci troviamo.
Ma quali potrebbero essere i rimedi?
Dobbiamo ridare allo Stato il proprio ruolo nell’economia, ma per farlo dobbiamo dargli le risorse, evitando l’attuale costante gioco al ribasso con la fiscalità e di sbandierare le paure che aumentando le imposte otterremmo solo di allontanare i buoni contribuenti. La fiscalità non è che uno dei fattori per la scelta di dove insediarsi, al quale se ne aggiungono altri, come la qualità di vita, dei servizi, la sicurezza e la stabilità o, nel caso delle aziende, le qualifiche e l’operosità della mano d’opera.
Pietro Gianolli